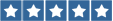Licenziamento a causa di diffamazione
[massima]
[fattoediritto]
Cassazione civile sez. lav. del 21 giugno 2011 n. 13575
Con ricorso al Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona in data 4-1- 2000 P.R., già assistente sociale coordinatore presso la locale Azienda Ospedaliera “G.M. Lancisi”, impugnava il licenziamento disciplinare con preavviso e contestuale disposizione di suo immediato allontanamento dal servizio – con conseguente pagamento in suo favore dell’indennità di preavviso – adottato nei suoi confronti con provvedimento del 31-5-1999, in esito al procedimento disciplinare conclusosi il 24 precedente.
Al riguardo la ricorrente assumeva l’infondatezza degli addebiti e, in particolare, che era stata oggetto di provvedimenti disciplinari ingiusti e illegittimi e che le espressioni usate in un esposto inviato all’Autorità competente, relativo ai fatti accaduti il 6-10- 1998, poste alla base del recesso datoriale, erano sarcastiche o ironiche, ma non offensive, minacciose o calunniose nei confronti della medesima.
Radicatosi il contraddittorio, l’Azienda Ospedaliera convenuta resisteva al ricorso deducendo la legittimità del licenziamento.
Nel corso del procedimento la convenuta veniva fusa per incorporazione con l’Azienda Ospedali Riuniti Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi. La causa era perciò interrotta e quindi riassunta dalla ricorrente nei confronti della incorporante.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1006/2004, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Con ricorso del 28-9-2005 la P. proponeva appello, con varie censure, avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.
La azienda appellata si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 20-11-2007, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
In sintesi, ritenute tardive e inammissibili le eccezioni di nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 29, comma 2 CCNL 1-9-1995 e per mancata corrispondenza tra l’originaria contestazione e le motivazioni poste a base del provvedimento stesso, nonchè le circostanze fattuali ulteriori non esposte nel ricorso introduttivo di primo grado – in particolare sia “quelle inerenti alle controversie lavorative (non disciplinari) oggetto di giudizio innanzi al TAR” allegate nella prima udienza, sia “gli altri episodi dedotti addirittura con il ricorso di appello” (aggiungendo peraltro che comunque le prime non erano sintomatiche di un atteggiamento persecutorio nei confronti della dipendente e i secondi neppure risultavano provati) -, la Corte territoriale rilevava che il primo giudice non aveva fondato il proprio giudizio sulla sentenza penale di primo grado che aveva condannato la P., ma aveva autonomamente e diffusamente analizzato le circostanze del caso e, in particolare, il contenuto della denuncia del 23-12-1998.
Valutato nuovamente in particolare, poi, tale contenuto, la Corte d’Appello ha osservato che “le espressioni utilizzate dalla P. vanno ben al di là della critica (anche aspra) all’operato dei dirigenti, per trasmodare in aperte contumelie, addirittura, in addebiti di fatti di rilevanza penale”, di guisa che “l’esposto era oggettivamente idoneo a gettare gravissimo discredito sui dirigenti del L., di cui venivano messe in discussione non soltanto la competenza professionale, ma anche l’onestà intellettuale”.
Sulla base di tale rilievo, sufficiente, per la sua gravità, a giustificare il licenziamento, la Corte di merito riteneva, quindi, “ininfluente il giudicato penale nel frattempo formatosi in ordine alla non punibilità della P., a mente dell’art. 598 c.p. per il reato previsto dal precedente art. 595, in base al principio posto dall’art. 653 c.p.p., comma 1, con l’aggiunta apportatavi dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, comma 1, lett. B)”, e ciò in quanto la esimente de qua “se è idonea ad escludere la punibilità della diffamazione come reato, non priva il fatto della sua illiceità in ambito extrapenale”, come quello disciplinare.
La Corte d’Appello concludeva, quindi, affermando che “la condotta della P., tanto sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, si è tradotta in una gravissima lesione dei doveri di fedeltà e di rispetto della reputazione della parte datoriale, tale da produrre l’irreversibile lesione dell’elemento fiduciario e quindi, anche sotto il profilo della proporzionalità, l’inflizione della sanzione espulsiva”.
Per la cassazione di tale sentenza la P. ha proposto ricorso con nove motivi, corredati dai relativi quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. che va applicato nella fattispecie ratione temporis.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. Lancisi – G. Salesi” ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 653 c.p.p., come modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, la ricorrente, premesso che con sentenza n. 18097 del 10-4-2006 è stata assolta in via definitiva dalla 5^ Sezione penale della Corte di Cassazione dal reato di diffamazione “perchè il fatto non costituisce reato” e considerata la “assoluta identità oggettiva della incolpazione disciplinare e di quella penale, nonchè la assoluta coincidenza soggettiva nel giudizio penale e nel giudizio civile determinata dall’avvenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel procedimento penale”, in sostanza lamenta che la Corte di merito avrebbe eluso “totalmente il senso e la portata innovativa dell’art. 653 c.p.p., come modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1”, negando che la detta assoluzione abbia autorità di giudicato nel presente giudizio.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, sotto altro profilo, avrebbe violato l’art. 598 c.p. in relazione all’art. 653 c.p.p. e art. 2909 c.c., “non tenendo conto che il giudice penale aveva stabilito, con effetto di giudicato nella presente controversia, che le espressioni usate dalla ricorrente avessero connessione immediata e diretta con l’oggetto della controversia, nonchè rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno delle tesi prospettate dalla ricorrente, proprio in quanto aventi origine e causate dalla pluralità di procedimenti disciplinari intentati nei suoi confronti e tendenti a dimostrare l’esistenza di una vera persecuzione a suo carico”.
In sostanza la ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Ancona avrebbe “violato il contenuto del giudicato penale considerando le frasi contenute nell’esposto mere contumelie non aventi origine e connessione diretta ed immediata con la pluralità dei procedimenti disciplinari, nonostante il manifesto contrario avviso del giudice penale, nonchè “addebiti di rilevanza penale” nonostante l’assoluzione definitiva della ricorrente dal reato di calunnia” (per “insussistenza del dolo”, passata in giudicato a seguito della citata sentenza penale della Corte di Cassazione) e conseguentemente avrebbe “errato nel ritenere le frasi contenute nell’esposto come comportamento idoneo a giustificare il licenziamento intimato alla ricorrente”.
Tali motivi, connessi fra loro, risultano infondati.
Ai sensi dell’art. 653 c.p.p. (come modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1, recante “norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, tra le quali sono comprese le “aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale” – v. D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1 mod. dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 1, ed ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2 -) “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”.
Vero è che per effetto della modifica operata dalla L. n. 97 del 2001 “l’efficacia di giudicato – nel giudizio disciplinare – della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perchè “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, anche a quella del “fatto non costituisce reato” (con la conseguenza, tra l’altro, che, qualora l’addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest’ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare” – v. Cass. S.U. 8-3-2006 n. 4893, Cass. S.U. 25-6-2008 n. 17441).
E’ pur vero, però, che in tale ultima ipotesi, l’efficacia del giudicato riguarda in particolare l’accertamento che “il fatto non costituisce reato” (accertamento logicamente successivo all’accertamento del fatto e della sua commissione).
Considerato, inoltre, che l’art. 653 c.p.p. integra una delle specifiche limitate eccezioni (vedi anche gli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) al principio generale della autonomia tra il giudizio civile e quello penale dettato dal medesimo codice del 1988 (v. fra le altre Cass. 2-8-2004 n. 14770), ritiene il collegio che l’accertamento che “il fatto non costituisce reato”, così delimitato, non può giungere ad impedire una diversa valutazione del fatto medesimo sotto il profilo dell’illecito disciplinare (in tali sensi cfr, fra le altre, Cass. S.U. 19-9-2005 n. 18451, v. anche Cons. Stato Sez. 6^ 30-7-2010 n. 5035, Cons. Stato Sez. 4^ 7-7-2009 n. 4359).
Del resto, con riguardo all’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, questa Corte ha precisato che tale esercizio incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza di tutela della persona umana, per cui “ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio” il comportamento del lavoratore può giustificare il licenziamento “pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione” (v. Cass. 24-5-2001 n. 7091, Cass. 24-9-2003 n. 14179). Ed inoltre, proprio con riferimento alla esimente prevista dall’art. 598 c.p. la Corte Costituzionale ha rilevato che “la tutela della libertà della difesa non attribuisce peraltro una singolare facoltà di offendere, giacchè tutti gli atti ed ogni condotta nel processo debbono rispecchiare il dovere di correttezza, anche nelle forme espressive usate dalle parti, e l’esimente per le offese arrecate non ne elimina il disvalore, nè esclude sanzioni di tipo diverso da quelle penali, come le sanzioni disciplinari … o reazioni ulteriori..” (v. C. Cost. n. 380/1999).
Va pertanto enunciato, ex art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi di assoluzione con sentenza irrevocabile perchè “il fatto non costituisce reato”, il giudicato penale, ai sensi dell’art. 653 c.p.p. (come modificato dalla L. n. 97 del 2001, art. 1), non preclude in sede disciplinare una autonoma valutazione del fatto stesso, in quanto l’illecito penale e quello disciplinare operano su piani differenti e ben può un determinato comportamento del dipendente rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale”.
Orbene nella fattispecie legittimamente la Corte di merito ha proceduto ad una autonoma valutazione degli elementi di fatto, non preclusa nè dalla assoluzione dal reato di diffamazione a norma dell’art. 598 c.p. nè dalla assoluzione dal reato di calunnia per “insussistenza del dolo” (che appunto ha escluso tale elemento soggettivo del reato ma non il fatto oggettivo materiale).
Con il terzo motivo la P., denunciando violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 7, in sostanza lamenta che la Corte di merito avrebbe violato le dette norme “omettendo di valutare lo stato soggettivo della ricorrente, in relazione al complessivo quadro conflittuale esistente tra le parti, come risultante in atti per effetto del giudicato penale, nonchè dagli stessi documenti prodotti dalla resistente avanti al Tribunale di Ancona, prendendoli inoltre in considerazione comportamenti non facenti parte della contestazione degli addebiti e della motivazione del licenziamento”, così errando nel giudicare proporzionata la sanzione inflitta.
In particolare la ricorrente deduce che la sua reazione “non poteva non ritenersi collegata allo stato soggettivo, alla collera ed al senso di mortificazione dovuti alla ingiustizia che ella stava subendo e che pertanto non poteva assumere una tale gravità da consentire la sanzione espulsiva”.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sullo stesso punto.
Anche tali motivi risultano infondati.
Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito “in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso istituzionalmente rimesso al giudice del merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere si di lui incombente L. n. 604 del 1966, ex art. 5, deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicchè l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto”, (v.
Cass. 14-1-2003 n. 444, Cass. 25-2-2005 n. 3994, Cass. 16-5-2006 n. 11430, Cass. 24-7-2006 n. 16864, Cass. 10-12-2007 n. 25743, Cass. 22- 3-2010 n. 6848).
Orbene nella fattispecie la Corte di merito ha attentamente preso in esame e valutato il contesto nel quale si era verificato il fatto contestato, considerando anche la situazione di conflittualità esistente tra le parti e lo stato soggettivo della P., nonchè, come elemento ulteriore, il comportamento successivo della stessa.
In particolare la Corte territoriale, analizzate le tre iniziative disciplinari, anteriori alla contestazione, allegate con il ricorso introduttivo (ed escluse le ulteriori allegazioni tardive) ha ritenuto che “il contesto che ne risulta non appare contraddistinto da una condotta persecutoria nei confronti della lavoratrice o, comunque, da una situazione di conflittualità ascrivibile a colpa della parte datoriale”, aggiungendo che “anche volendo ammettere che la P. avesse maturato del risentimento nei confronti dei dirigenti, ritenuto nel proprio intimo giustificato, ciò non può comunque giustificare l’iniziativa assunta di screditarli attraverso la presentazione di un esposto che, prendendo lo spunto dal ricordato episodio, si era tradotto nelle riferite gravissime accuse e contumelie nei loro confronti”. Inoltre e sempre ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo la Corte ha considerato anche la condotta successiva ed in particolare lo scritto difensivo del 21-5- 1999, concludendo che “la condotta della P., tanto sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, si è tradotta in una gravissima lesione dei doveri di fedeltà e di rispetto della reputazione della parte datoriale, tale da produrre l’irreversibile lesione dell’elemento fiduciario e da legittimare quindi, anche sotto il profilo della proporzionalità, l’inflizione della sanzione espulsiva”.
Tale motivazione, oltre che conforme al principio sopra richiamato, risulta altresì congrua e resiste alle censure della ricorrente contenute nel terzo e quarto motivo.
Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione degli art. 1421 c.c., artt. 416 e 437 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., in sostanza deduce che la Corte di merito, anzichè ritenere inammissibili perchè tardive le eccezioni di tardività della contestazione degli addebiti ex art. 29, comma 2 CCNL 1-9-95 e di mancanza di corrispondenza tra le condotte contestate e le mancanze poste a base del licenziamento, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della sanzione disciplinare per tali ragioni.
Anche tale motivo risulta infondato.
Come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui ribadito “qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa (o di giustificato motivo soggettivo) costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l’accertamento della nullità del medesimo licenziamento per l’inosservanza, a vario titolo, della procedura prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale ulteriore prospettazione comporta la deduzione di un’altra, diversa causa petendi, con l’inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, nè tale nullità può essere rilevata dal giudice, ex art. 1421 c.c., poichè il principio della rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado, della nullità deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato” (v. fra le altre Cass. 17-2-2003 n. 2363, Cass. 7-6-2003 n. 9167, Cass. 20-4-2005 n. 8264).
Nella fattispecie la Corte d’Appello legittimamente ha escluso la rilevabilità d’ufficio della nullità del licenziamento sia per la violazione dell’art. 29, comma 2 del CCNL 1-9-95 (dedotta per la prima volta con l’appello) sia per la asserita mancata corrispondenza tra l’originaria contestazione e le motivazioni del licenziamento (sollevata per la prima volta con la memoria del 19-12-2002) rilevando per entrambe la novità della causa petendi e quindi della relativa domanda.
Peraltro con riferimento alla seconda la Corte territoriale ha affermato che sul punto il primo giudice aveva diffusamente argomentato anche sulla infondatezza della asserita nullità e tale decisione non era stata censurata dalla appellante, con conseguente giudicato interno.
Orbene tale decisione neppure è stata censurata dalla ricorrente.
Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e art. 437 c.p.c., comma 2, in sostanza deduce che la Corte di merito, anzichè ritenere tardiva e inammissibile la produzione documentale fatta dopo il deposito del ricorso introduttivo, in primo grado, nonchè quella ulteriore effettuata in grado di appello, “avrebbe dovuto ammettere tale produzione avvalendosi dei propri poteri d’ufficio ex art. 437 c.p.c., comma 2, contemperando il sistema di preclusioni con l’esigenza della ricerca della verità materiale, in quanto poteva trattarsi di documenti indispensabili ai fini della decisione”, in specie in ordine alla valutazione complessiva dei rapporti conflittuali tra le parti.
Con il settimo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 4, anche in relazione all’art. 420 c.p.c., con riferimento alle due sentenze del TAR Marche prodotte all’udienza del 18-7-2000, deduce che erroneamente la Corte ne ha ritenuto la inammissibilità, posto che “la produzione documentale era avvenuta con il consenso della resistente che aveva anche preso esplicita posizione ed accettato il contraddittorio sulle circostanza fattuali” di cui alle dette sentenze.
Con l’ottavo motivo la ricorrente, denuncia vizio di motivazione sul punto di cui al settimo motivo.
Anche tali motivi (sesto, settimo e ottavo), connessi fra loro, risultano infondati.
Come è stato affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato, “nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento” (v. Cass. 26-5-2010 n. 12856, v. anche Cass. S.U. 17-6-2004 n. 11353, che ha evidenziato l’obbligo per il giudice “di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso”).
Nella fattispecie, attenendosi a tali principi, la Corte di merito, sulle due sentenze del TAR allegate nella prima udienza, legittimamente ha rilevato la novità delle circostanze fattuali, “implicanti l’esigenza di ulteriori accertamenti ed insuscettibili di rilievo d’ufficio”, “ancorchè la parte resistente non si fosse opposta alla produzione dei documenti” detti.
Peraltro, sul punto, la Corte ha anche rilevato nel merito, con congrua motivazione in fatto, che “l’esistenza di controversie giudiziarie inerenti all’inquadramento professionale non è in alcun modo sintomatica di un atteggiamento persecutorio nei confronti della dipendente, alla cui tutela, peraltro, l’ordinamento predispone gli opportuni strumenti processuali”, tanto più in considerazione anche della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione, risultante dalle dette sentenze.
Per quanto riguarda, poi, gli “altri episodi” dedotti con il ricorso di appello, legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile per tardività la produzione dei documenti al riguardo effettuata in secondo grado, rilevando in particolare che neppure poteva farsi ricorso ai poteri istruttori d’ufficio “stante il loro riferimento a fatti non tempestivamente allegati”.
Tale motivazione, oltre che conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì sufficiente e priva di vizi logici.
Infine con il nono motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’Appello avrebbe errato la valutazione delle risultanze probatorie “non avvedendosi che la più ampia sequenza dei procedimenti disciplinari nonchè la pretestuosità di gran parte degli stessi, come risultante dalle stesse specifiche incolpazioni e denunciata nel ricorso introduttivo, era stata ritualmente prodotta in atti dalla resistente mediante la produzione dei documenti allegati alla memoria di costituzione del 7- 7-2000”.
Il motivo risulta inammissibile in quanto privo di autosufficienza e del tutto generico.
Ripetutamente questa Corte ha affermato il principio secondo cui “il ricorrente che denuncia sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto” (v. fra le altre Cass. sez. 1^ 17-7-2007 n. 15952, Cass. 20-2-2003 n. 2527, Cass. 25-8-2003 n. 12468, Cass. sez. 3^ 20-10-2005 n. 2032), essendo “necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti” (v. Cass. sez. 3^ 24-5-2006 n. 12362, Cass. sez. 3^ 26-6-2007 n. 14751, Cass. sez. 3^ 26-6-2007 n. 14767).
Peraltro, come pure è stato più volte precisatogli controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa”, (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).
Orbene la ricorrente non solo non riporta specificamente il contenuto dei documenti che sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito, ma neppure ne indica la decisività, al di là della generica affermazione della asserita pretestuosità delle iniziative disciplinari.
Per il resto la censura si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” ed in sostanza di riesame del merito.
Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese, liquidate in Euro 49,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011