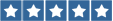Responsabilità dello Stato per fatto doloso del magistrato
[intestaz]
Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-01-2014, n. 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7265/2007 proposto da:
T.G. ((OMISSIS)) e D.M.F. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato CAPPONI BRUNO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE CRISTOFARO, il primo in forza di procura speciale in calce al ricorso ed il secondo giusta procura speciale del Dott. MARIO SACCO Notaio in ESTE, del 21/02/2012, REP. 119.909;
– ricorrenti –
contro
D.R.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELON CLAUDIO e GIACOBBE GIOVANNI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 18/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 20/01/2006, R.G.N. 437/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato MARCO DE CRISTOFARO;
udito l’Avvocato CLAUDIO MICHELON;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
[fatto]
1. – Con sentenza resa pubblica il 20 gennaio 2006, la Corte di appello di Trento respingeva il gravame interposto da T. G. e D.M.F., avvocati, avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 6 aprile 2004, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile, in base alla L. 13 aprile 1988, n. 117, la domanda di risarcimento danni che le stesse avevano proposto contro D.R.G., giudice dal Tribunale di Padova, assumendo di esser state da costui diffamate allorquando, in sede di udienza collegiale di un giudizio civile, il D.R., presidente del collegio, dopo aver rigettato un’istanza di rettifica e d’integrazione del verbale d’udienza (asseritamente contenente errori e omissioni pregiudizievoli per l’assistito delle attrici), ordinava l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio dell’ordine degli avvocati ed al P.M. per i provvedimenti di competenza, reputando l’istanza stessa gravemente lesiva della dignità, onorabilità e correttezza del presidente e del collegio; trasmissione che, secondo le stesse attrici, “aveva un contenuto ingiurioso e diffamatorio nei loro confronti”.
1.1. – La Corte territoriale respingeva, anzitutto, l’eccezione di nullità della sentenza, sollevata in ragione dell’omessa fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 180 c.p.c., e del mancato esperimento dell’istruttoria. A tal riguardo, il giudice di appello osservava, che, nel corso della prima udienza di comparizione, a seguito dell’eccezione di inammissibilità dell’azione proposta dal convenuto, il giudice istruttore del Tribunale adito aveva concesso termine alle parti per deduzioni (sino al 15 giugno 2003), con ulteriore termine per repliche (sino al 30 giugno successivo), rinviando poi per la precisazione delle conclusioni “in ordine alla questione preliminare” all’udienza del 3 dicembre 2003. Ciò precisato, la Corte di appello sosteneva che “lo sdoppiamento della prima udienza” era stato adottato dal legislatore di cui alla L. 20 dicembre 1995, n. 534 “essenzialmente a tutela del convenuto”, per metterlo “al riparo dal rischio di incorrere nella decadenza relativa alla proposizioni di eccezioni in un momento anteriore alla comparizione delle parti”; sicchè, risultava “singolare che a lamentarsi della mancata fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c., siano state proprio le attrici alle quali è stato consentito di impostare la causa secondo la strategia difensiva prescelta”.
Inoltre, quanto all’omessa istruttoria, la Corte territoriale soggiungeva che essa appariva del tutto superflua a motivo della dirimente eccezione di inammissibilità del convenuto, che si fondava su “questione strettamente giuridica”.
1.2. – In ordine poi alla dedotta erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’azione, per aver il Tribunale ritenuto inapplicabile nel caso di specie la L. n. 117 del 1988, art. 13, giacchè operante solo nel caso di contestuale esercizio dell’azione penale o là dove sia accertata l’esistenza di un reato in sede penale, il giudice del gravame confermava la soluzione seguita dal giudice di primo grado, osservando che il filtro di ammissibilità dell’azione di responsabilità civile nei confronti di un magistrato, di cui all’art. 5 della citata legge – previsto a tutela dell’esercizio della funzione giurisdizionale, giacchè volto ad impedire “azioni avventate e dal sotteso intento ricattatorio ed intimidatorio”, tali da limitare l’indipendenza del giudice – non si rendeva necessario soltanto a fronte di una responsabilità del magistrato costituente reato, in ragione della gravità della condotta. Tuttavia, le parti attrici non avevano prescelto la via del giudizio penale, che avrebbero potuto intraprendere tramite proposizione di querela e successiva costituzione di parte civile, ma avevano agito in sede civile, rimanendo cosi soggette “alle formalità richieste dalla legge”.
1.3. – La Corte territoriale riteneva, inoltre, manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale reiterate dalle appellanti, sia per asserita irragionevole equiparazione di trattamento del magistrato in caso di responsabilità derivante da illecito civile ed illecito penale, sia per dedotta disparità di trattamento tra il magistrato e gli altri pubblici dipendenti in caso di responsabilità penale, sia, infine, per l’irragionevole limitazione del diritto di azione del cittadino nei confronti del magistrato.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono T. G. e D.M.F. affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.
Resiste con controricorso D.R.G..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La difesa delle ricorrenti ha presentato, ai sensi dell’art. 379 c.p.c., osservazioni scritte sulle conclusioni rese dal pubblico ministero in pubblica udienza.
[diritto]
1. – Con il primo mezzo è dedotta violazione della L. n. 117 del 1988, art. 13, per “erroneità dell’interpretazione accolta dal Giudice di appello in merito alla necessaria proponibilità dell’azione civile di risarcimento per i danni derivanti da fatto- reato commesso dal magistrato – non preceduta da sentenza penale irrevocabile nè svolta in sede di costituzione di parte civile – nelle forme e nei termini previsti dall’art. 5”.
Le ricorrenti, nel dare atto dell’esistenza di un orientamento consolidato del giudice di legittimità in ordine all’interpretazione della L. n. 117 del 1988, art. 13, nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata, svolgono articolate considerazioni a sostegno di una lettura diversa e non riduttiva di detta norma, intesa a superarne presunte aporie ed incongruenze. A tal riguardo, contestano che possa ritenersi valido l’argomento “storico” della correlazione sistematica tra la L. n. 117 del 1998, e il codice di procedura penale del 1930 (all’epoca dell’emanazione di detta legge ancora vigente), il quale contemplava l’istituto della pregiudiziale penale necessaria, posto che sarebbe “poco plausibile” opinare che il legislatore dell’epoca ignorasse i contenuti della riforma del codice anzidetto, che solo dopo pochi mesi sarebbe entrata in vigore, eliminando detto istituto giuridico, come del resto già era evidente in base ai criteri della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81.
Quanto all’argomento della compromissione delle garanzie fondamentali di autonomia ed indipendenza del giudice, le ricorrenti obiettano che l’ingiusta accusa nei confronti del magistrato sarebbe controbilanciata “dalla concreta possibilità dell’irrogazione della sanzione prevista per il reato di calunnia” e che, per altro verso, non sarebbe invocabile l’istituto della ricusazione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 3, che, in ogni caso, dovrebbe essere filtrata, ai sensi degli artt. 53 e 54 c.p.c., attraverso una delibazione preliminare di “consistenza” e “rilevanza” dell’azione di responsabilità civile.
Si evidenzia, poi, che l’opzione ermeneutica seguita dalla giurisprudenza comporta “una sostanziale completa irresponsabilità” dei magistrati, che “finiscono con l’essere tutelati da tale inasprimento delle condizioni di esercizio dell’azione risarcitoria” e implica, altresì, “il discutibile mantenimento per i soli giudici del pregresso regime di pregiudizialità penale necessaria rispetto all’azione civile risarcitoria”.
Le anzidette incongruenze sarebbe superate da una “piana lettura” dell’art. 13, che lasciasse al danneggiato la scelta di costituirsi o meno nel processo penale ovvero di agire in sede civile “direttamente e liberamente” per conseguire il risarcimento del danno conseguente a fatto-reato del magistrato, che, concernendo condotte che “esulino dall’ambito specifico dell’esercizio delle attività decisorie”, non andrebbe “inesorabilmente” a sovrapporsi alle ipotesi contemplate dalla stessa L. n. 117, art. 2, rispetto alle quali soltanto si rende armonica la previsione dell’art. 4, comma 2, della citata legge, in ordine alla subordinazione dell’esercizio dell’azione risarcitoria contro lo Stato “al previo esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o degli altri rimedi previsti in pendenza del procedimento”.
In conclusione le ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto (sebbene non imposto a pena di inammissibilità, non trovando applicazione ratione temporis, nel presente giudizio, l’art. 366-bis cod. proc. civ., essendo la sentenza impugnata precedente già alla sua stessa entrata in vigore): “è erronea l’interpretazione della L. n. 117 del 1988, art. 13, nel senso che esso esige che l’azione di responsabilità diretta verso il magistrato per fatti costituenti reato debba necessariamente essere esercitata mediante costituzione di parte civile o previa condanna irrevocabile nel processo penale? Corrisponde ad una lettura corretta della predetta norma, nel combinato disposto con la L. n. 117 del 1988, art. 2, ritenere che tali condizioni di ammissibilità debbano essere rispettate solo laddove il reato addebitato al magistrato inerisca alle sue funzioni decisorie, là dove invece, allorchè esso attenga ad altre condotte penalmente rilevanti del giudice, l’azione risarcitoria ben può essere esercitata direttamente in sede civile prescindendo da qualsiasi filtro di ammissibilità della domanda?”.
Le ricorrenti, nell’ipotesi in cui si ritenga di ribadire l’interpretazione consolidata dell’art. 13, reiterano le eccezioni di illegittimità costituzionale della medesima norma, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 28 Cost., già delibate con esito negativo dalla Corte di appello.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta “nullità del procedimento e della sentenza di appello: mancata dichiarazione di nullità del procedimento e della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 180 e 183 c.p.c., e conseguente omessa rinnovazione degli atti malli da parte del Giudice di seconde cure ex art. 354 c.p.c., comma 4”.
Le ricorrenti, adducendo la scrutinabilità del secondo motivo in “ipotesi di rigetto della prima doglianza”, assumono che, nel corso dell’udienza di prima comparizione del giudizio di primo grado, a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’azione sollevata dal convenuto, il giudice istruttore “invitava le parti a precisare le conclusioni per un’udienza all’uopo fissata, pretermettendo la fissazione dell’udienza di trattazione”. Tale vizio di mancata piena attuazione del contraddittorio veniva denunciato con l’atto di appello e la Corte territoriale escludeva che potesse sussistere, argomentando sullo sdoppiamento delle udienze posto a tutela del convenuto, con ciò errando, in quanto la fissazione della prima udienza di trattazione ha carattere inderogabile ed è a tutela delle posizioni di tutte le parti del giudizio.
Viene formulato il seguente quesito di diritto: “essendo la prima udienza di trattazione posta, nel sistema preclusivo dettato dalle L. n. 353 del 1990, e L. n. 534 del 1995, a tutela del diritto di difesa di entrambe le parti, la sua mancata fissazione determina la carente attuazione del contraddittorio, provocando la nullità degli atti successivi e della sentenza ai sensi dell’art. 159 c.p.c., si che il giudice di appello, al quale sia denunziato tale vizio, è tenuto a dichiarare la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado e a rinnovare gli atti caducati ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4, rimettendo le parti in termini per l’espletamento delle attività di cui all’art. 183 c.p.c.?”.
3. – Priorità logico giuridica impone di scrutinare dapprima il secondo motivo di ricorso, giacchè con esso è posta questione di mancata attuazione del contraddittorio sin dal primo grado, facendosene discendere la nullità della sentenza in esso pronunciata, quale vizio radicale non rilevato in appello.
Il motivo è inammissibile.
In tal senso, non viene tanto in discussione il principio più generale per cui le norme in forza delle quali la L. 20 dicembre 1995, n. 534, (di conversione del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432) ha regolato la sequenza delle udienze di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c., siano poste a tutela del diritto di difesa delle parti ed abbiano natura tendenzialmente inderogabile (Cass., 27 maggio 2005, n. 11318; Cass., 6 giugno 2011, n. 12242), quanto, piuttosto, rileva il fatto che, a fronte di un denunciato vulnus inferto al contraddittorio, che conseguirebbe dal mancato rispetto della anzidetta sequenza procedimentale, le ricorrenti non abbiano poi allegato alcuna specifica lesione derivata al proprio diritto alla difesa in giudizio, adducendo in via del tutto generica di aver perduto la facoltà di precisare o modificare domande e deduzioni a seguito dell’eccezione di inammissibilità dell’azione sollevata dal convenuto, senza, però, indicare di quali precisazioni o modifiche si trattasse. Nè si afferma in ricorso che tali specifiche indicazioni abbiano avuto luogo in appello (o già in sede di scambio delle memorie in primo grado, cui la Corte territoriale ha annesso valenza al fine della realizzazione di un effettivo contraddittorio tra le parti) e ciò a fronte della stessa affermazione resa dal giudice di secondo grado in ordine all’insussistenza di un pregiudizio patito dalle appellanti a seguito della mancata fissazione dell’udienza ex art. 183 c.p.c.. Così come la stessa parte ricorrente non ha dedotto di aver semmai richiesto, già con dette memorie di primo grado, una rimessione in termini per l’espletamento dell’udienza di trattazione.
Del resto, anche in relazione alla affermazione del giudice del gravame in ordine alla superfluità dell’eventuale attività istruttoria in ragione di un thema decidendum concentrato su una questione di mero diritto, le ricorrenti non hanno allegato quali avrebbero potuto essere i contenuti utili di detta istruzione probatoria.
Trova, dunque, applicazione nella specie il principio, consolidato, secondo cui la parte, che alleghi la nullità della sentenza per vizio radicale del procedimento, è tenuta a dimostrare che da tale vizio sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d’interesse; ciò in quanto non è dato configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, necessitando invece la prospettazione, a fondamento dell’impugnazione, delle ragioni per le quali la dedotta lesione del contraddittorio stesso abbia comportato l’ingiustizia del processo, causata dall’impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette (tra le altre, Cass., 20 novembre 2009, n. 24532; Cass., 21 marzo 2011, n. 6343).
4. – Venendo, dunque, all’esame del primo motivo, esso è infondato.
4.1. – La decisione della Corte territoriale è in linea – come del resto riconosciuto dalle stesse ricorrenti – con l’indirizzo consolidato di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, e che può compendiarsi nella seguente massima: “in tema di responsabilità civile del magistrato, la L. n. 117 del 1988, art. 13, nel prevedere l’azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell’esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dall’art. 2 e ss., della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino – rispetto all’ipotesi di dolo di cui all’art. 2 – un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di P.C. nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato. Ne consegue che, qualora il soggetto leso prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per il compimento di reati da parte di magistrati nell’assolvimento delle funzioni istituzionali, la relativa domanda (anche per fatti anteriori al 16 aprile 1988 e proposti successivamente al 7 aprile 1988, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 468 del 1990, incidente sulla L. n. 117 del 1988, art. 19) non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall’art. 5 della richiamata legge, in quanto ove il (preteso) danneggiato potesse liberamente agire in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati i limiti ed il filtro imposti dalla legge all’ammissibilità dell’indicata azione” (Cass., 7 maggio 2007, n. 10295. Analogamente, tra le altre, Cass., 16 novembre 2006, n. 24387; Cass., 4 maggio 2005, n. 9288; Cass., 29 aprile 2003, n. 6697; Cass., 22 febbraio 2002, n. 2567; Cass., 20 settembre 2001, n. 11880; Cass., 13 dicembre 2000, n. 15710; Cass., 24 novembre 2000, n. 15192; Cass., 4 novembre 1998, n. 11044).
La solidità di un tale orientamento non è scalfito dalle ragioni, ampiamente argomentate, che le ricorrenti oppongono con il ricorso (e ulteriormente sostengono con la memoria ex art. 378 c.p.c.), posto che le presunte aporie che il medesimo orientamento produrrebbe si risolvono tramite un duplice, ma integrato, piano di lettura della L. n. 117 del 1988, là dove su quello dell’esegesi dogmatica, in forza dei criteri letterale, storico e sistematico, si innerva, in modo vivificante, il piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata, la cui preminenza porta con sè l’effetto di rendere resistente l’impianto complessivo della normativa implicata anche in presenza di (eventuali) distonie.
4.2. – Lo spettro tramite il quale illuminare la trama normativa rappresentata dalla L. n. 117 del 1988, artt. 2, 4, 5 e 13, è quello delle disposizioni di cui agli artt. 101 e ss. della Costituzione, che imprimono alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati un significato d’insieme univoco e coerente di difesa dei valori dell’autonomia ed indipendenza del giudice, i quali operano non già come privilegio personale del singolo appartenente all’ordine giudiziario o alle giurisdizioni speciali (art. 108 Cost.), bensì come tassello indefettibile, al pari di altri, nella costruzione della forma repubblicana, che, ai sensi dell’art. 139 Cost., non può in nessun caso essere oggetto di revisione. Con l’ulteriore rilievo che un siffatto vincolo si riverbera anche sulla non negoziabilità dei diritti che la prima parte della Costituzione definisce inviolabili e che del tipo di ordinamento cosi delineato dal Costituente costituiscono un substrato essenziale, il cui presidio, in termini di tutela ed effettività, si rinviene, nel loro svolgersi storico, anche (seppur non solo) nell’esercizio stesso della giurisdizione, la quale non può che essere riservata ad un organo imparziale ed indipendente. Sicchè, l’autentico significato che l’indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale è proprio quello della garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini. In altri e più pregnanti termini, “il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell’ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l’applicazione imparziale e indipendente della legge”: un bene che appartiene “alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini” (Corte cost., sentenza n. 497 del 2000).
Si tratta di una chiave di lettura il cui saldo ancoraggio nella giurisprudenza costituzionale ha consentito allo stesso Giudice delle leggi di riconoscere, nello specifico della materia regolata dalla L. n. 117 del 1988, “il rilievo costituzionale di un meccanismo di filtro della domanda giudiziale, diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perchè un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando ad escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezioni dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. da 101 a 113 Cost., nel più ampio quadro di quelle “condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati” che “la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono” (sentenza n. 468 del 1990, che richiama anche le precedenti sentenze n. 2 del 1968 e n. 26 del 1987).
Analogamente, con la sentenza n. 18 del 1989, la stessa Corte costituzionale ha affermato che, poichè la disciplina dell’attività del giudice deve essere tale da rendere quest’ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma al tempo stesso il magistrato è soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d’indipendenza e quello di responsabilità, “non merita censura una disciplina della responsabilità civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l’indipendenza dei magistrati nonchè l’autonomia e la pienezza dell’esercizio della funzione giudiziaria”.
Nè può ritenersi che una tale prospettiva abbia perso di vigore a causa dell’impatto del diritto eurounitario, siccome interpretato dalla Corte di Giustizia U.E., sulla legge n. 117 del 1988 (CG, 24 novembre 2011, in C-379/10; più in generale sulla responsabilità dello Stato per violazione del diritto eurounitario imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado: CG,, del 30 settembre 2003, in C-224/01, Kobler; CG, 13 giugno 2006, in C-173/03, Traghetti del Mediterraneo), là dove i principi di autonomia e di indipendenza del giudice (e la loro valenza costituzionale) non sono messi affatto in discussione, venendo, tuttavia, collocati su un piano differente rispetto a quello su cui si poggia la responsabilità dello Stato per l’illecito comunitario, che non attiene a quella personale del giudice.
Dunque, se tali sono le fondamenta che sostengono la disciplina in esame, la lettura che ne segue deve essere, pertanto, costituzionalmente orientata dai suindicati valori, da garantire e preservare, e tramite siffatta peculiare lente vanno, per l’appunto, traguardate e risolte le eventuali disarmonie che la stessa legge n. 117 del 1988 possa in ipotesi esibire.
4.3. – Invero, sebbene originata in un clima già maturo per accogliere la riforma del codice di procedura penale, non è dato dubitare che la disposizione di cui al citato art. 13 sia entrata in vigore allorchè l’anzidetto sistema processuale di riferimento ancora contemplava, quanto all’azione civile di danno, la c.d.
pregiudizialità penale e che, proprio attraverso siffatto meccanismo, l’esercizio dell’azione civile in sede penale o il formarsi del giudicato penale sul fatto reato ascritto al magistrato venivano a rappresentare (in continuità con il passato, segnato dall’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 56, terzo comma, cod. proc. civ.; cfr. tra le altre, Cass. n. 9288 del 2005, cit.) gli strumenti mediati, in luogo del filtro tipizzato dalla medesima L. n. 117, art. 5, per soddisfare l’esigenza di tutela della autonomia ed indipendenza del giudice nei cui confronti si fosse inteso agire per farne valere la responsabilità civile.
Al di là, però, dell’esegesi storica che attiene alla genesi dell’art. 13, occorre considerare la collocazione della norma nell’attuale modularsi dell’ordinamento – che è, poi, quanto rileva ai fini della presente controversia – il quale ora consente, in linea generale, di proporre l’azione civile risarcitoria direttamente in sede civile, senza più il necessario tramite del giudizio penale (art. 75 c.p.p., comma 2).
Con ciò l’ambito operativo dell’art. 13 viene in rilievo in dipendenza di una scelta difensiva da parte del (preteso) danneggiato dal fatto-reato addebitato al magistrato; ove tale sia il percorso eletto, la norma mantiene intatta la sua originaria portata, sicchè l’azione risarcitoria “può essere esercitata soltanto in sede penale, mediante costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, e, direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato” (Cass. n. 9288 del 2005, cit.). Solo così inteso, l’art. 13 può ritenersi in armonia con gli articoli della Costituzione diretti a garantire l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del magistrato.
In altri termini, l’estensione della deroga al di fuori di dette ipotesi, sulla scorta della sola circostanza che la parte istante abbia dedotto la configurabilità come reato del contegno ascritto al magistrato, vanificherebbe, infatti, le finalità perseguite con detto controllo di ammissibilità, in quanto si affiderebbe alla mera prospettazione del soggetto in tesi danneggiato l’effetto di autorizzare il contradditorio immediato e diretto con il magistrato, cosi eludendo un istituto di garanzia approntato a difesa della funzione giurisdizionale, non del singolo soggetto che la esercita (Cass. n. 6697 del 2003, cit.).
Garanzia che non è evidentemente surrogabile con la sola tutela penalistica conseguente ad una possibile denuncia per calunnia da parte del magistrato infondatamente accusato del fatto-reato, posto che – come ribadito da questa Corte anche successivamente alla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso – “se non vi fosse un filtro tra la parte e il giudice, ogni litigante in malafede potrebbe liberamente promuovere azioni di responsabilità civili contro magistrati non graditi, accusandoli della commissione di uno o più reati, e considerare tali pendenze quali presupposti di astensione e/o ricusazione del magistrato stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 c.p.c., n. 3, con l’effetto di sottrarre alla controversia il suo giudice naturale” (Cass. n. 9288 del 2005, cit.).
4.4. – Ma, una volta venuta meno la c.d. pregiudizialità penale, il (preteso) danneggiato dal fatto costituente reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni può anche optare per l’esercizio dell’azione risarcitoria direttamente in sede civile.
Tuttavia, l’azione civile diretta, proprio perchè vanno essere garantiti e presidiati i valori costituzionali della autonomia ed indipendenza del giudice, deve essere proposta secondo la procedura di cui alla stessa L. n. 117 del 1988, art. 13 e preceduta dal filtro di ammissibilità di cui al successivo art. 5 (Cass. n. 15710 del 2000, cit.; Cass. n. 11880 del 2001, cit.; Cass. n. 2567 del 2002, cit.).
4.5. – La diversa impostazione che propongono le ricorrenti, sebbene adduca talune disarmonie nel sistema cosi ricostruito (alcune già scrutinate e superate, altre, come nell’ipotesi di prolungate indagine preliminari, costituenti solo degli inconvenienti di fatto:
cfr. Cass. 24 dicembre 2002, 18329), pretermette, però, ogni efficace presidio a tutela dei valori costituzionali implicati nel contesto in esame, posto che, a fronte del fatto-reato, si assume non necessario un filtro (quale che sia) di ammissibilità dell’azione civile; il che comporta una lettura essa stessa distonica da quella che dovrebbe essere orientata dai principi costituzionali più volte richiamati.
Invero, il complesso delle ragioni sostenute dalle ricorrenti ruota, essenzialmente, intorno ad una premessa fondante (da cui si traggono le conclusioni di maggior respiro e pregnanza, sviluppate poi anche nella memoria), che non può essere condivisa.
La tesi è che la disciplina di cui all’art. 2 e quella recata dalla stessa L. n. 117 del 1998, art. 13, sarebbero divergenti – e non convergenti – giacchè la prima riguarderebbe gli illeciti commessi nell’esercizio dell’attività propriamente giurisdizionale – definita come “istituzionale attività decisoria del Giudice” – mentre la seconda riguarderebbe illeciti che esulerebbero “dall’ambito specifico dell’esercizio delle attività decisorie”. Di qui anche il richiamo, nelle osservazioni scritte presentate in udienza, alla possibilità di configurare l’azione diretta ai sensi della L. n. 117 del 1998, art. 13, allorquando non sussista, o venga meno, “il vincolo di occasionalità necessaria tra comportamento e funzione”, quale apprezzamento di fatto esclusivamente rimesso al giudice del merito.
4.5.1. – Tuttavia, contrariamente a quanto addotto dalla parte ricorrente, è da apprezzare, sotto il profilo dei comportamenti rispettivamente considerati, una sostanziale sovrapponibilità tra l’art. 2 (là dove, segnatamente, contempla il dolo del magistrato) e l’art. 13 e ciò non solo per il fatto che è assai difficile ipotizzare un dolo civile distinto da quello penale (Cass. n. 11880 del 2001, cit.), ma anche, e soprattutto, per la circostanza che il presupposto oggettivo della stessa disposizione di cui art. 2 – e dell’intera L. n. 117 del 1988 – non è l’esercizio di funzioni giurisdizionali in senso stretto, siccome inteso dalle ricorrenti, bensì quello di funzioni giudiziarie, che, dunque, estende l’ambito di applicazioni della legge anche oltre l’attività eminentemente decisoria. In tal senso, depongono chiaramente l’art. 1 (ove si richiama la “attività giudiziaria” e la “funzione giudiziaria”) e lo stesso art. 2, là dove viene fatto riferimento non soltanto al danno ingiusto per effetto di un “provvedimento giudiziario”, ma anche al “comportamento” e all'”atto” posto in essere dal magistrato, così intendendo, ancora una volta, non circoscrivere la portata delle norme di cui alla L. n. 117 in riferimento alla sola funzione strettamente giurisdizionale, assunta come attività decisoria.
Peraltro, una siffatta lettura non è affatto smentita – come, invece, sostengono le ricorrenti – dalla disposizione di cui alla medesima L. n. 117 del 1988, art. 4, la quale, oltre a condizionare l’azione risarcitoria all’esperimento dei rimedi (impugnatori o di altro genere) avverso i “provvedimenti” decisori in senso lato, individua anche l’ipotesi in cui detti rimedi non siano previsti, così da ancorare la medesima azione al mero esaurimento del grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il “fatto che ha cagionato il danno”, con ciò mostrando di contemplare anche un’azione risarcitoria per fatto che origini esclusivamente da un comportamento o da un atto che non siano espressione di attività decisoria, anch’essi – come già detto – al pari dei provvedimenti, inclusi, dalla citata L. n. 117 del 1988, art. 2, nel novero delle ipotesi di esercizio delle, più ampie, funzioni giudiziarie.
Dunque, rilevando anche per l’applicabilità della stessa L. n. 117, art. 13, l’esercizio di “funzioni giudiziarie”, alla stessa stregua di quanto necessita per il citato art. 2 (mantenendosi la differenziazione tra le ipotesi dolose di cui a quest’ultima disposizione ed i fatti-reato ex art. 13 nel solco del solo quid pluris richiesto dal medesimo art. 13, e cioè l’esercizio dell’azione civile nel giudizio penale o il previo formarsi del giudicato penale rispetto all’azione risarcitoria in sede civile), si rende irrilevante l’indagine sulla sussistenza, o meno, di un “vincolo di occasionalità necessaria con l’esercizio della funzione decisoria in senso stretto” postulato dalle ricorrenti. Del resto, in tale direzione si è già orientata questa Corte, allorchè ha enunciato il principio per cui “la responsabilità dello Stato, ai sensi della L. n. 117 del 1988, art. 13, comma 1, per i danni conseguenti a fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ed accertati dal giudice penale, non è esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali, ma mosso da motivi personali ed egoistici, quando l’atto stesso, indipendentemente dalla sua concreta rispondenza o meno alle esigenze di giustizia, sia comunque collegato all’espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell’ambito di un procedimento quale forma di trattazione dello stesso” (Cass., 24 novembre 2000, n. 15192).
Ne consegue, altresì, che, nella specie, non ricorre affatto l’ipotesi, evocata con le osservazioni ex art. 379 c.p.c., di mancato accertamento di un fatto da parte del giudice del merito (da cui si fa discendere una cassazione con rinvio della decisione gravata), giacchè – come emerge dalla stessa sentenza impugnata – sono state proprio le ricorrenti a fondare l’azione risarcitoria, direttamente intentata in sede civile, su una vicenda pianamente inerente ad espletamento di “funzioni giudiziarie”, evidenziando che, nel corso di un procedimento civile, a seguito della richiesta di rettifica ed integrazione del verbale d’udienza collegiale, il presidente del collegio (magistrato poi convenuto in giudizio con azione risarcitoria diretta) rigettava l’istanza e, ritenuta la lesiva della dignità ed onorabilità sua e dello stesso collegio, ne ordinava la trasmissione al consiglio dell’ordine degli avvocati ed al p.m.;
trasmissione del provvedimento che le attuali ricorrenti reputavano di “contenuto ingiurioso e diffamatorio nei loro confronti”.
Trattasi, dunque, di premessa fattuale incontestata, sulla quale si è calata la decisione della Corte territoriale e che, come detto, non implica la verifica di quel nesso di “occasionalità necessaria” ipotizzato dalle ricorrenti.
4.6. – Le complessive considerazioni che precedono rendono evidente, infine, l’inconsistenza delle questioni di legittimità costituzionale che le ricorrenti nuovamente deducono in questa sede, dopo che le stesse sono state ritenute inidonee dalla Corte territoriale (e già dal giudice di primo grado) a dar luogo ad un incidente di costituzionalità.
Giova appena soggiungere, sempre nel senso della manifesta infondatezza delle prospettate questioni, quanto segue.
In riferimento alla asserita irragionevole equiparazione di situazione differenti, quali sarebbero quelle della responsabilità del magistrato derivante da illecito civile e da illecito penale, è sufficiente ribadire che le due fattispecie (peraltro, sovrapponibili, come visto, sotto il profilo dei comportamenti, dolosi, rispettivamente considerati) sono ispirate dalla medesima ratio, che è quella di tutela dei valori dell’autonomia e dell’indipendenza del giudice, per cui si rende comunque necessaria, per entrambe, una fase preliminare di ammissibilità dell’azione risarcitoria, che, nel concreto, può essere diversamente configurata dal legislatore.
In ordine, poi, alla pretesa disparità di trattamento tra magistrati e gli altri dipendenti pubblici, essendo soltanto per i primi contemplato un “privilegio processuale” a fronte di un illecito penale, è agevole rammentare, alla luce delle pronunce del Giudice delle leggi innanzi rammentate, che l’apprezzabile diversità tra le situazioni poste a raffronto, tale da elidere la consistenza stessa del giudizio di eguaglianza, è data dai presidi costituzionali dei quali soltanto il giudice gode.
Infine, quanto alla presunta violazione dell’art. 24 Cost., per la supposta necessità “- che ne conseguirebbe ex art. 3 (rectius: 4) l.
medesima – del previo esperimento di tutti i mezzi di gravame anche in caso di responsabilità civile del magistrato derivante da illecito penale”, occorre soltanto rilevare che l’eccezione muove da una non condividibile interpretazione dell’art. 4, come in precedenza si è evidenziato, sicchè, essendo erroneo il presupposto interpretativo (e le conseguenze che se ne traggono), per ciò stesso essa palesa la sua inconsistenza.
5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e le ricorrenti, in quanto soccombenti, condannate, in via solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014